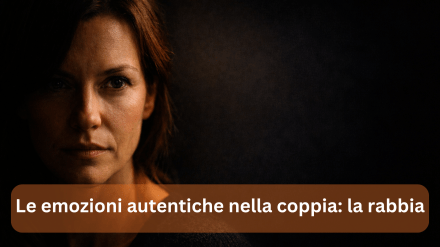Da qualche tempo assistiamo ad un fenomeno costante: il numero dei single è in crescente aumento e le coppie vanno incontro a sempre più frequenti separazioni. Questo ci spinge ad interrogarci alla luce dell’unica Parola che può far fiorire le nostre vite.
Leggendo il libro della Genesi, incontriamo il padre della fede, Abramo: sebbene avanti con l’età, egli desiderava più di ogni altra cosa un figlio ma si trovò a fare i conti con la sterilità di Sara, sua moglie. Nonostante le condizioni umane sembrassero suggerire un limite, Abramo ricevette da Dio la promessa di una “discendenza numerosa come le stelle del cielo”. (Gen 26,4) Per realizzare questo, Abramo seguì il Suo invito: lasciò la propria terra, la propria parentela e partì “senza sapere dove andava”. (Eb 11,8) E fu così che ricevette il dono del figlio tanto atteso, Isacco. A spingere Abramo a mettersi in cammino è la fede in quel Dio che gli si era rivelato: la Parola ci dice che egli “credette, saldo nella speranza contro ogni speranza”. (Rm 4, 18)
Dio sogna per ciascuno di noi una vita feconda: ciò che siamo chiamati a fare come prima cosa, proprio come Abramo, è metterci in cammino, lasciare le nostre certezze e uscire da noi stessi. Quello di cui facciamo esperienza è che ogni relazione, nella fase iniziale, sembra magica e destinata a regalarci la persona che abbiamo sempre sognato. Dopo poco tempo, però, l’idillio si spezza, emergono i conflitti, iniziamo a vedere i difetti dell’altro e le difficoltà ci appaiono insormontabili. La fine della relazione ci sembra l’unico orizzonte percorribile. In realtà, proprio in quel momento, può avvenire il vero cambiamento: accogliere le fragilità dell’altro come strumento per la via della santificazione, nostra e di chi abbiamo accanto.
Nella misura in cui permetto al rapporto di crescere, sto realizzando la mia vocazione. Nella misura in cui accolgo l’altro così com’è, con i suoi limiti e le sue fragilità, permetto all’amore di dimorare nel mio cuore. Il termine “compatibile” deriva dal latino e letteralmente significa “soffrire insieme”. La vera compatibilità è questa: se siamo disposti a soffrire l’uno per l’altro. “Chi comincia ad amare deve essere pronto a soffrire”, diceva Padre Pio. E proprio seguendo questo spirito possiamo realizzare la promessa dell’amore eterno, da rinnovare ogni giorno nel matrimonio, “nella gioia e nel dolore”.
“Una corda a tre capi non si spezza tanto presto” (Eccle 4,12), cita il libro dell’Ecclesiaste: laddove facciamo entrare Dio nella nostra relazione, l’amore acquisisce il tratto della solidità. Questa visione è agli antipodi di quello che ci propina il mondo: oggi, grazie anche ai nuovi strumenti di comunicazione, abbiamo la possibilità di conoscere sempre nuove persone tanto che l’altro ci sembra intercambiabile. Se una relazione non va, provo con un’altra e poi con un’altra ancora. La ruota può continuare all’infinito, nella speranza che prima o poi arrivi quella persona con cui tutto si incastra alla perfezione, senza sacrificio né fatica, ma questo è un grande inganno del nostro tempo. Ci hanno insegnato la fatica nello sport, la fatica nel lavoro e mai la fatica di portare “i pesi gli uni degli degli altri”. (Gal 6,2)
Una relazione in cui sono chiamato a fare verità può spaventare perché mi mette a nudo: attraverso i limiti dell’altro, sono chiamato a fare i conti anche con le mie fragilità, il mio egoismo e la mia incapacità di amare. Superare questa fase e aprirci alla comunione autentica con l’altro ci fa sperimentare un amore maturo, le cui fondamenta poggiano su pilastri solidi, e non sulle emozioni passeggere del momento.
Apriamoci allora a questo orizzonte, apriamoci alla promessa di un Dio che vuole regalarci una vita feconda, riconosciamo l’altro come un dono inviato dal Cielo e chiediamo al Signore di accrescere l’amore nel nostro cuore, vincendo il nostro egoismo. Solo così potremo realizzare la promessa di un amore eterno.
Francesca Parlangeli